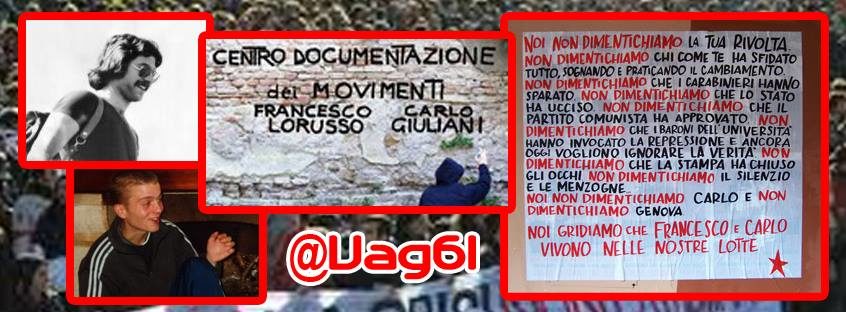Il 24 giugno a Vag 61 si è tenuta l’iniziativa “La radicalità narrativa di Valerio Evangelisti”
All’incontro hanno partecipato:
– Paola Papetti della casa editrice Odoya
– Alberto Sebastiani, ricercatore e giornalista (autore del libro “Nicolas Eymerich. Il lettore e l’immaginario in Valerio Evangelisti”)
– Mauro Baldrati (scrittore e redattore di Carmilla)
Sono state proiettate testimonianze video di Nicoletta Dosio, Serge Quadruppani e Alberto Prunetti.
Si è poi tenuto un reading con letture di testi di Valerio Evangelisti
Questo è il comunicato che presentava la serata:
“Sono passati due mesi dalla morte di Valerio Evangelisti, dovremo essere noi (tutti quelli che da lui in vita hanno ricevuto tanto) a far sì che le sue opere continuino a parlare.
Valerio resterà a lungo uno dei più grandi autori italiani, uno scrittore capace di farsi leggere – e tanto! e bene! – anche da lettori non avvezzi a seguire cicli narrativi.
Loriano Macchiavelli lo scorso 24 aprile sul suo sito ha scritto: “Eri il più bravo di tutti noi. Lo sarai per sempre”.
Sandro Moiso, un redattore di Carmilla, così l’ha descritto: “E’ stato un militante della letteratura, capace di raccontare episodi dimenticati della storia e di spiegare l’affermazione del capitalismo come sistema che regola i rapporti sociali tramite metafore racchiuse nelle sue saghe”.
Con le sue opere Valerio Evangelisti ha prodotto una vera e propria “resistenza dell’immaginario”-
In anni in cui le riviste specializzate italiane stavano chiudendo una dopo l’altra, Evangelisti con Carmilla ha contribuito a creare uno spazio in cui certi argomenti e certe scritture hanno assunto la rilevanza che il dibattito ufficiale italiano aveva negato per decenni.
Non sappiamo se Bologna dedicherà mai una strada, una piazza, un giardino o una sala pubblica a Valerio Evangelisti. La “città ufficiale” lo commemori (se lo farà) come meglio crede, ma gli spazi autogestiti, i collettivi, le organizzazioni politiche, gli archivi di movimento, i gruppi di base che Evangelisti ha frequentato e sostenuto debbono tenere vivi i suoi scritti e le sue idee, debbono continuare a far circolare i suoi libri, per il valore “universale” che rappresentano nella storia delle “classi oppresse”.
Vag 61 è un luogo che Valerio Evangelisti ha attraversato e aiutato con iniziative, presentazioni di suoi libri, festival letterari e prese di posizione politiche. Per queste ragioni e anche perché a Valerio eravamo legati e gli volevamo un gran bene, che abbiamo deciso di organizzare per venerdì 24 giugno un primo evento per ricordarlo e per lanciare per l’autunno una serie di iniziative che tentino di descrivere la sua impegnativa figura”.
Ciao Valerio
Ecco i testi che sono stati letti durante la serata.
LA FRATERNITA’
“So Long” è il nomignolo mi fu affibbiato da “Papalla” di Lotta continua. Derivava dalle sigarette che fumavo e dalla statura altissima. In quegli anni ci si chiamava essenzialmente per nome o soprannome. I cognomi riguardavano la polizia. Nessuno stava a chiederli.
Come So Long, dopo avere militato dal 1969 nella sinistra extraparlamentare e nelle sue tarde appendici, agli inizi degli anni Ottanta presi parte a due occupazioni di centri sociali: il Crack 1, ma soprattutto il Crack 2. In seguito mi convinsi che non ci sarebbe stata una rivoluzione in Italia, e che bisognava sostenere quelle in corso altrove. Assieme ad altri diedi così vita a un gruppo internazionalista, il circolo Carlos Fonseca. L’interesse per situazioni straniere, e in particolare per l’America latina, forse ci salvò dalla repressione durissima che si abbatté sul movimento.
Alle soglie degli anni Novanta promossi una rivista intitolata «Progetto Memoria». Ne nacque in seguito «Carmilla», fortunata esperienza prima cartacea e poi online. Questo è tutto ciò che posso dire di me stesso. Non senza avere dichiarato che, delle idee del passato, non ho mai rinnegato nulla, a parte aspetti molto marginali. Al contrario, quelle idee mi sembrano più attuali che mai.
La Rivoluzione francese, che tanta influenza esercitò sulle insurrezioni dei due secoli successivi, aveva un motto notorio: “Libertà, uguaglianza e fraternità”. La terza parola, la più trascurata, è quella che meglio definisce l’esperienza dei centri sociali. Laboratori di politica e cultura, certo, fucine di lotte e di forme alternative di svago, ma anche, in primo luogo, aggregazioni di individui che hanno deciso di aderire a un comune insieme di valori.
Ciò appartiene in fondo alla storia del movimento antagonista, sia antica che recente. Funzionavano grosso modo così le Case del popolo, risalenti ai primi del Novecento e, in qualche caso, all’ultimo decennio dell’Ottocento. Pensato alla stessa maniera era il circuito arci. Più vicini a noi, nel tempo e nello spirito, i circoli del proletariato giovanile degli anni Settanta, o le mense proletarie di Napoli e di altre località.
Quando la sinistra istituzionale (Pci, Psi) è entrata in crisi, le prime a essere liquidate sono state le Case del popolo, a favore di circoli e sezioni meramente politici aperti, di norma, un solo giorno a settimana. Tipo uffici. E quando a entrare in crisi è stata Rifondazione comunista, che alla “fraternità” non aveva dedicato molta attenzione, gli stessi circoli di partito hanno cominciato a chiudere i battenti.
A ben vedere, la sinistra antagonista si è sempre differenziata da quella istituzionale non tanto per questioni ideologiche (riforme o rivoluzione, elezioni o astensionismo, sindacato o organizzazione autonoma dal basso, e così via), quanto per la valorizzazione del momento esistenziale quale supporto a tutto il resto. E continua a farlo, più debole che in passato e tuttavia tenace.
Non sedimentò nulla, si dirà. Non è affatto vero. È alla sinistra “scomoda”, e non a quella imbolsita e oggi transitata a destra, che si devono la vittoria – attualmente messa in discussione, ma dopo due decenni – contro il nucleare, le più decise azioni antirazziste, il permanere di un antifascismo militante, il sopravvivere di un internazionalismo autentico, l’ancora larga diffusione di culture non ufficiali che passano di generazione in generazione, l’antimilitarismo, la critica dei sindacati accondiscendenti, la scoperta e l’uso di mezzi di comunicazione alternativi, la genesi di nuovi generi musicali, letterari e pittorici (i graffiti tanto odiati dal potere), la prima affermazione di massa del femminismo, l’antiproibizionismo.
Se tanti giovani si fossero affidati alla sinistra “storica”, oggi non sopravvivrebbe nulla di tutto ciò. Essa fece del suo meglio per reprimere le nuove idee, pose al centro del discorso una lenta penetrazione nelle istituzioni, poltrona per poltrona, assessorato per assessorato. Mobilitò spie, esaltò la delazione, usò la forza solo contro chi la contestava da sinistra. Oggi si può dire soddisfatta… Ogni giorno borbotta e gorgoglia qualcosa, che ha regolarmente a che fare con la pace sociale.
Di fronte, quella sinistra diventata con disinvoltura destra ha sempre avuto, come spina nel fianco, alcune migliaia di oppositori abituati a vivere assieme, a coltivare una comune visione del mondo, a esplorare le vie verso una società più umana. Non che le contraddizioni siano mancate. Litigi continui, incertezze, voltafaccia. Assenza totale, per la fuga in massa degli intellettuali “amici”, di un coerente quadro teorico.
Nel passato eravamo appartenuti a tendenze differenti. Non erano mancati gli scontri. Ma che conta? Eravamo vissuti assieme, avevamo passato uniti traversie indescrivibili. Malgrado fratture a getto continuo, una compattezza rimane. Siamo il partito della fraternité. È giusto, urgente e necessario rintracciarne le origini.
È questa solidarietà duratura la nostra forza autentica.
Andatelo a spiegare a un ex pcista “pidduino”, non capirà una parola.
I libri, negli anni settanta, mi hanno reso parte di un intellettuale che c’era e che in parte c’è ancora, l’intellettuale collettivo. È una consapevolezza dovuta al fatto che si viveva insieme, con discorsi e valori comuni, scazzi e discussioni, ma valori condivisi rimasti nel tempo che io cerco di tradurli per iscritto. E quel che c’era ai tempi del romanzo, di grande, erano le case del popolo, le camere del lavoro, i locali dove si beveva, sì stava insieme, si metteva in piedi uno spirito comune. Vorrei che quello spirito tornasse, così come la voglia di ribellarsi… ne vale sempre la pena.
DI CHI PARLO
Parlo di contadini e di braccianti, di povera gente che ha dato alla Romagna e all’Emilia la propria impronta. Senza curarsi troppo di chi, a livello politico, pretendeva di averne la guida. L’unico linguaggio per me adeguato era quello brusco, essenziale, a volte sarcastico o umoristico delle campagne. Quanto è risultato da questa colossale trasformazione dal basso è soddisfacente, oggi? Non sono problemi miei. Io scrivo romanzi…
La narrativa di genere non è un blocco unico, quale spesso viene dipinto. Fantascienza e horror non sono consolanti per nulla, e non lo è nemmeno il Noir, che ha intriso di pessimismo il giallo classico. Tutto ciò, ovviamente, non implica automatiche valenze sovversive. Queste possono emergere se si elabora un progetto consapevole, come ha fatto Manchette col Noir francese…
Trovo ridicoli e assurdi gli scritti degli storici che tentano di riabilitare l’Inquisizione. A mio parere si collocano nella generale ondata di “revisionismo” che investe la storiografia, e che mira a difendere, in nome dell’anticomunismo, manifestazioni di barbarie e di oscurantismo: l’Inquisizione, certo, ma anche il fascismo, il nazismo, ecc. Mentre si attaccano la rivoluzione francese, la resistenza al nazifascismo, le battaglie per la democrazia, e tutti i momenti storici in cui si è fatta strada l’idea di eguaglianza. In Italia questa tendenza è molto forte, ma temo che si tratti di un fenomeno europeo.
Quanto al valore delle mie cose paragonato ad altri autori, non è un mio problema. Io scrivo quello che mi sento, so benissimo di non avere uno stile particolare, ma cerco lo stile più efficace in quel momento. A volte, la frase può risultare estremamente poetica ma non è che io cerchi la frase poetica, butto giù. Quando mi metto a scrivere sono come invasato. Mi getto e vivo quelle storie lì, le vivo fino infondo. Se poi non vengono capite, ritenute grezze o cose del genere va beh, a me basta già che ci siano tanti lettori che mi seguono e che mi vogliono bene.
IL SOLE DELL’AVVENIRE
Mio padre era dell’Appennino, mia madre imolese, e nel sole dell’avvenire parlo di storie che sentivo raccontare da bambino. Mia nonna aveva un altarino pieno di santini, e accanto a Gesù c’era Andrea Costa. Ma soprattutto nel romanzo parlo del contesto sociale in cui quel movimento è nato, di quell’anima romagnola che esiste, una specificità della Romagna, in prima linea nel Risorgimento, nell’Internazionale, nel socialismo, in cui i Repubblicani erano rivoluzionari contro la monarchia e scendevano in piazza con la bandiera rossa.
A Forlì e Faenza prevalevano i mezzadri, a Ravenna e a Molinella i braccianti. Questi vivevano nelle periferie, e il loro rapporto con la terra era diverso dai mezzadri: si ritenevano operai e avevano forme di lotta violente, estreme, assurde per i contadini, come il galletto rosso, cioè incendiare i campi, o il boicottaggio, l’isolamento totale di chi faceva qualcosa contro l’organizzazione dei lavoratori. Nessuno serviva né rivolgeva la parola a un crumiro che entrava in osteria o in un negozio, e chi lo faceva era boicottato a sua volta… Allo sciopero i padroni rispondevano chiamando i crumiri, protetti dall’esercito, perciò o ti arrendi o li boicotti isolandoli, costringendoli ad andarsene…
LA COMUNE DI PARIGI
Il Comitato centrale, fatto di sconosciuti provenienti da fabbriche e bottegucce, da officine e lavoro ambulante, non pretende il potere. Si adopera perché si elegga un governo democratico, con mandati limitati, possibilità di revoca dei nominati, stipendi da operaio. È la Comune di Parigi, di netto orientamento socialista. Sorretta dai club, organismi spontanei di democrazia diretta, partorirà in due mesi provvedimenti di natura sociale tali da oscurare quanto si era fatto nei decenni precedenti, e persino nella breve oasi di libertà del 1848.
Il tentativo di cambiamento avviene nel mezzo di battaglie accanite contro i versagliesi, le diffamazioni contro la Comune di una Repubblica fasulla che non esita ad allearsi ai prussiani, contraddizioni, screzi interni, errori clamorosi (tipo l’astenersi, “per onestà”, dal prendere possesso della Banca centrale, del Catasto e degli altri istituti fiscali). La fame, le penurie dell’assedio, i tradimenti di sedicenti “progressisti” non impediscono al primo governo dichiaratamente socialista di battersi come un leone, senza smettere di legiferare.
Sull’altro fronte la reazione della borghesia è quella da sempre, tipica di quella classe. Il massacro. Si fucilano i prigionieri senza processo, si pavimenta di cadaveri la città riconquistata. Seguirà un decennio di imprigionamenti, di esecuzioni e di deportazioni in Nuova Caledonia. Hanno osato troppo, quelle canaglie. Che paghino.
I carnefici hanno però trascurato la nascita di un bambino. Ha appena acquistato coscienza, è ancora fragile. Si chiama proletariato. Divenuto adulto, manifesterà se stesso in mille occasioni. E, tante volte, la classe dominante avrà poco da sorridere. Quando vuole, quando recupera coscienza, il piccolo è capace di mordere.
IL LINGUAGGIO NEI LAGER
Nei lager erano rinchiusi prigionieri di varia nazionalità. La reciproca incomprensione voleva dire non poter beneficiare dell’esperienza dei più anziani, ignorare le poche regole per cercare di sopravvivere, non sapere come far fronte alle ricorrenti malattie, essere all’oscuro degli espedienti per procurarsi un po’ di cibo. Come se non bastasse, gli italiani erano particolarmente odiati, perché, se agli occhi delle SS erano dei voltagabbana, a quelli di russi, polacchi, francesi erano fascisti e basta. Da cui un supplemento di vessazioni.
Come si resisteva, il più possibile, in quegli inferni sospesi nel nulla, in cui era inevitabile perdere la nozione del tempo? Bisognava imparare le parole essenziali per non scontentare gli aguzzini, e anche un linguaggio misto, con vocaboli in varie lingue deformate e soprattutto in tedesco e in polacco, nato spontaneamente nelle camerate. Linguaggio oggi perduto, solo orale e mai scritto, a parte brevi e rare iscrizioni sulle pareti.
L’OMINO DAL CACCIAVITE IN MANO: IL SABOTAGGIO
Esiste una forma di lotta che ha gli effetti di uno sciopero di massa, pur se attuata da un numero esiguo di lavoratori o, in certi casi, persino da uno solo?
Sì, esiste, e si chiama sabotaggio.
Era comune, e teorizzata da alcune forze sindacali, nei primi decenni del secolo scorso, soprattutto in Francia, in Inghilterra e in America. A quei tempi, in Italia, era praticata principalmente nelle campagne.
Tornò di moda, da noi, negli anni Settanta. Noto è il caso, ai tempi della catena di montaggio, del cosiddetto “salto della scocca” nella industria automobilistica. La vettura completata mancava di qualche pezzo piccolo ma essenziale, e ciò la rendeva inservibile. Un danno economico altissimo per il padrone. Nel 1984 vi fu un processo contro alcuni operai dell’Alfa Romeo colpevoli del sabotaggio. A sorpresa, i magistrati condannarono l’azienda e assolsero i lavoratori. Una sentenza che, in certi ambienti e sulla stampa mainstream, fece scandalo…
Émile Pouget, un dirigente della CGT di tendenza anarco-sindacalista, nel 1911 scrisse un libro dal titolo “Il sabotaggio”.
Sosteneva che «il sabotaggio delle industrie consiste (…) nel ridurre la macchina, o qualsiasi altro strumento di lavoro, in istato di inattività impedendo, così, che l’arma escogitata dalle classi padronali – il crumiraggio – possa spuntare quella delle classi operaie – lo sciopero (…)
Bisogna che i capitalisti sappiano che il lavoratore non rispetterà la macchina se non quando questa sia divenuta per lui un’amica che abbrevia il lavoro, invece di essere, come oggi è, la nemica che gli ruba il pane e lo uccide».
Di Pouget era pure la formula che riassume il concetto: «A cattiva paga, cattivo lavoro». Questa parola d’ordine scomparve in seguito dal novero degli slogan sindacali.
Riapparve per un poco in Italia, negli anni Settanta, nella forma «A salario di merda, lavoro di merda».
Lo direste mai, oggi, che un congresso del congresso sindacale potesse adottare il sabotaggio come arma legittima? Questo avvenne a Tolone a un congresso della CGT:
«Noi vi abbiamo già dimostrato come istintivamente il lavoratore abbia risposto al capitalista feroce diminuendo la produzione, ossia offrendo un lavoro proporzionato alla miserabilità del salario».
«Occorre augurarci che i lavoratori si rendano conto che il sabotaggio, per divenire un’arma poderosa, deve esser praticato con metodo e con coscienza…. Con l’auspicio che il sabotaggio entri nell’arsenale di lotta dei proletari contro i capitalisti, analogamente allo sciopero, e che l’orientazione del movimento sociale abbia sempre più la tendenza all’azione diretta degli individui e a una maggiore coscienza della propria personalità».
Di seguito le tavole della mostra su Valerio Evangelisti che è stata allestita.